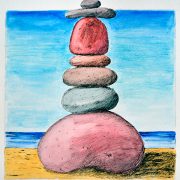In un’epoca in cui il cuore diviene l’immagine più diffusa al mondo, un emoji da scambiarsi via social, un quadro devozionale sui muri della Casa di Giulietta a Verona, un fregio per magliette, borse, cravatte, abiti e accessori vari, nel momento in cui la sua stilizzazione pre e post pop, da Mirò a Frida Khalo passando per Chagall, tra Peynet, Keith Haring e Niki de Saint Phalle, dal Cuore Sacro di Jack Kerouac ai cuori iperkitsch di Jeff Koons, affrontare il tema nelle arti plastiche costituisce a priori una sfida. Dove il tipo viene abusato, lo stereotipo si solidifica rendendo concreto per l’artista il rischio di finire nel pozzo del già visto, già consumato, prossimo alla nausea. Per quanto le variazioni sul tema siano moltiplicabili all’infinito, la riconoscibilità dell’immagine brucia ogni sorpresa e categorizza in modo sommario l’operazione relegandola tra le rappresentazioni non interessanti per l’eccessiva celebrità del modello. Questo perché quel tanto di dolciastro sopravvissuto quale residuo deleterio del Movimento Romantico pare essersi condensato nella rappresentazione semplificata di un organo da sempre trasferito metaforicamente dalla sfera anatomica a quella dei sentimenti.
In un’epoca in cui il cuore diviene l’immagine più diffusa al mondo, Stefania Tramarin decide di affrontare l’argomento dedicandogli un’opera monumentale quanto a serialità, tanto impegnativa da fissarsi nell’obiettivo ambizioso di un disegno al giorno per 365 giorni. Un anno ipotecato nell’attività che Baudelaire definisce sorella dell’ispirazione, il lavoro giornaliero, un’impresa entusiasmante da ideare ma non facile da realizzare.
Nel farlo, il pensiero dell’artista si espande e dalla semplice stilizzazione del cuore, organo sentimentale privo di sesso, l’idea si accresce del contrappunto periodico di altre due stilizzazioni, corrispondenti agli organi sessuali dei due sessi. Quello femminile in verità gode di due differenti visualizzazioni: l’una piana, emblematica, che dell’evocazione “botanica” ritiene la genuina rappresentazione un tempo mimata nelle manifestazioni femministe unendo le due mani in un bacio verticale, l’altra tratteggiata nel vuoto tra le due cosce nude della donna, inquadrate di fronte, sarcastico trompe-l’oeil di un predicatore a braccia spalancate verso un cielo corporeo. Così il misticismo intorno alla fertilità, da cui prende significato l’etimologia di “felice”, quadra il cerchio di una ricerca formale felicemente indovinata. Le tre figure, che sono quattro, s’incontrano tra loro di tanto in tanto a mo’ di riassunto e puntualizzazione delle molte, differenti fasi del discorso. I cuori si inanellano l’uno nell’altro citando stili e movimenti artistici, tematiche concettuali e superficiali profondità, alternandosi di tanto in tanto a falli perfettamente identificabili, pur trasfigurati in figure stranianti di cactus o motociclisti appiedati, e a vulve prese di piatto o di fronte, inglobate nell’insieme di una vitalità sentimentale che non nega alla carne la stretta connessione con lo spirito.
Il cuore diventa così il terzo e onnicomprensivo organo genitale, quello che li contiene entrambi e ne combina i generi con sorprendente fluidità. Uno dei due organi femminili riproduce di tanto in tanto un cuore nel suo centro del piacere, mentre i cuori chiamano a raccolta i due organi femminili e quello maschile in una sorta di sinergia riassuntiva prima di riprendere il loro viaggio nelle diverse tappe che dagli spettri ai castelli, dalle nuvole alle lacerazioni conducono lo spettatore lungo un anno d’amore che ne concentra forse una sessantina, tale è l’età anagrafica dell’artista messasi in gioco.
Perché di gioco si tratta, lo si evince dal tocco di umorismo che emana da alcune opere e da alcune serie d’immagini sconfinanti dal lirico nel drammatico, quando non nell’horror, in un’andata e ritorno senza frontiere evidenti. Dal puzzle scomposto e riunito alle manipolazioni bioniche, dalla serie chirurgica all’animalier, dal pop di Lichtenstein squisitamente citato in una vertigine abissale all’assurdo di Escher, dal fumetto a Halloween, dal surrealismo magrittiano all’autoritratto cubista, dal grandguignol al minimalismo, dall’incompiuto al sovrabbondante, dal barocco al classicheggiante, e ancora, di tecnica in tecnica, dal disegno a china al pennarello, dall’acquarello alla tempera, dalla matita all’acrilico: tutto testimonia la potenza dell’immaginazione applicata alla quotidianità in una dissertazione inevitabilmente filosofica a proposito dell’amore e del sesso. I castelli di carte crollano, i gironi infernali sembrano macine di mulino, i sonetti scespiriani si raccolgono in immagine, schiere di alfabeti e grafemi affluiscono come sangue a cuori e falli e defluiscono in vulve generose e austere, i mostri dell’inconscio ghignano mentre i genitali fanno bella mostra di sé diventando altro da sé in dimensioni cardiache inesplorate tra la satira e la beffa del sistema sentimentale globale.
Ci eravamo tanto amati ma come? Con quali organi esattamente e preposti a cosa? Era il cuore a pompare sangue nelle cavità cavernose del membro virile o era la vulva ad agitare gli ormoni dell’amore? Quale ossitocina circola in quale organo per assecondare i desideri e i ricordi di quali desideri? Se per Andy Warhol il sesso non è che la nostalgia del sesso, per Stefania Tramarin non è che irrisione dei suoi trascorsi prefigurati con la Caduta in un avvenire quotidiano già spersonalizzato, il gioco di bimba di una donna troppo consapevole per cascarci ancora senza averlo profondamente deciso.
Le zip si aprono e chiudono su amori arcobaleno in borsette zebrate sinuose fino alla civetteria. Membri rigorosi e affermativi fanno la figura dei gemelli che li sostengono, proverbialmente di scarsa intelligenza, vulve devote a sacerdoti ascetici si confrontano con la geometria sensuale dell’origine del mondo. Tutto ciò che ne esce entra nel cuore che circolarmente s’intreccia al suo itifallo da esposizione senza che alcuna pornografia intervenga nel più remoto pensiero dell’artista né dello spettatore. Il turbamento iniziale di vedere simboli destinati ai muri delle latrine pubbliche accostati all’icona più glicemica del millennio sfuma presto nella complessità poetica di una mescolanza mai osata prima, e tanto ripetuta da rendersi finalmente credibile.
Si tentenna allora, e si esita ad ammettere che il più delle volte in cui si pensava di porre il cuore in primo piano era qualcos’altro a trasparire o a muovere gli intenti. Dall’altra parte si comprende come ciò che spesso governava incontrollatamente gli impulsi genitali non fosse che il travestimento di sentimenti tanto profondi da risultare inconfessabili. E tutto questo senso esplode non da una singola opera o da una raccolta di poche decine di disegni, ma dal lavoro assiduo di un anno, accumulo e sommatoria di esperienze vissute, sognate, ricordate, immaginate da una donna che nell’arte ha saputo porre un ragionamento universale, nato non dalla visceralità espressiva propria dell’artista ma dalla sua genitalità concentrata e allargata a infrangere l’utilizzo fasullo e convenzionale del cuore umano. Come un motteggio sensuale di Marilyn Monroe denuda in sé l’esuberanza femminile che si appella alla maschia irrazionalità, così la raccolta dei Cuori Genitali di Stefania Tramarin smaschera la menzogna sdolcinata dell’amore avulso dal sesso per ricondurre la verità nella sfera complessiva di due dimensioni inseparabili, irrimediabilmente compromesse. Allora il cuore smette di essere icona abusata alla festa di San Valentino e riacquista la povera dignità umana di Eva e Adamo davanti all’Albero, più genitale che genealogico, da cui tutti si discende.
Stefania Tramarin – Cuori genitali 2021